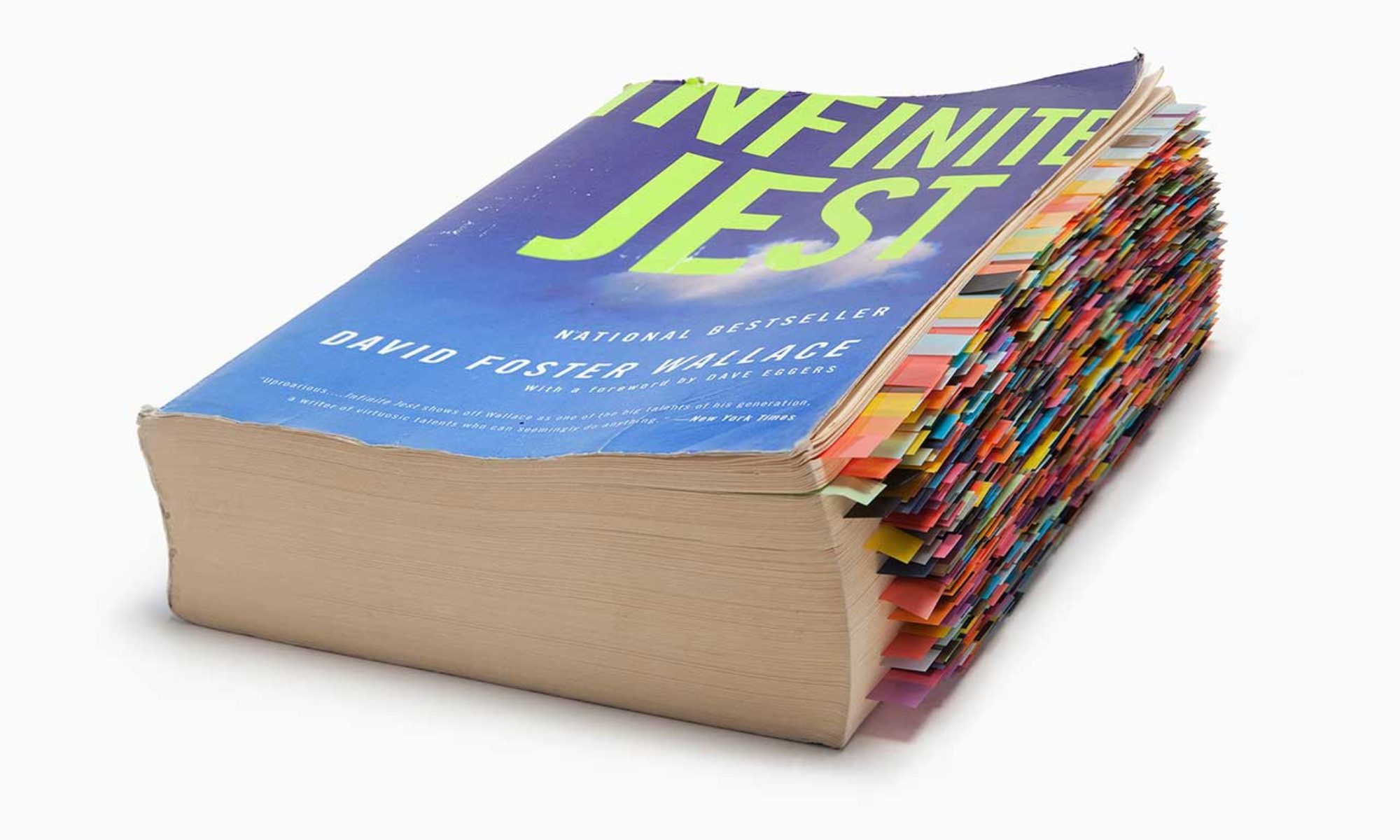Domenica sera sono tornato in Italia, dopo una settimana di viaggi in giro per l’Europa in cui mi sono occupato molto poco dei media italiani. Al mio arrivo, come faccio quando ricordo di farlo, ho chiamato i miei genitori per avvisarli che ero atterrato sano e salvo e stavo tornando a casa. Quando ho sentito mio padre abbiamo finito per litigare: a suo dire correvo un rischio molto serio, c’è una pericolosa epidemia in corso.
Le mie letture sul tema le ho fatte, non attingendo al classico paniere informativo italiano, e ho una percezione che ritengo equilibrata della questione: per lui, che si è abbeverato solo ai canali TV nazionali, invece siamo sull’orlo del disastro. 60 milioni di abitanti in Italia, due focolai che hanno fatto appena 250 contagiati (o poco di più), 7 morti che però pare fossero tutti pazienti affetti da altre patologie gravi. Per lui è pandemia.
Non si può minimizzare, certo: ma, a casa in smart working grazie alla disponibilità del mio giornale, mi sono reso conto guardando mezza giornata la TV italiana del perché mio padre l’altra sera sia andato su tutte le furie (e io lo stesso). Abbiamo una gravissima responsabilità, noi giornalisti, per come abbiamo gestito questa faccenda: e la responsabilità va su nella gerarchia fino ai direttori, visto che sono loro a dettare la linea a tutta la redazione. Mi domando a cosa servano, comunque, tutti quei balenghi corsi di aggiornamento e formazione che ci propinano: difronte a una situazione di questo tipo, la categoria ha dato prova di una grandissima dose di dilettantismo in materia di informazione su un tema critico.
PS: Con mio padre ci siamo chiariti. Poveraccio, non mi hai mai perdonato di tifare per la Juventus.
PS: A oggi i contagi hanno superato quota 300, 10 decessi – tutti pazienti in età avanzata e con altri tipi di patologie gravi già in essere.