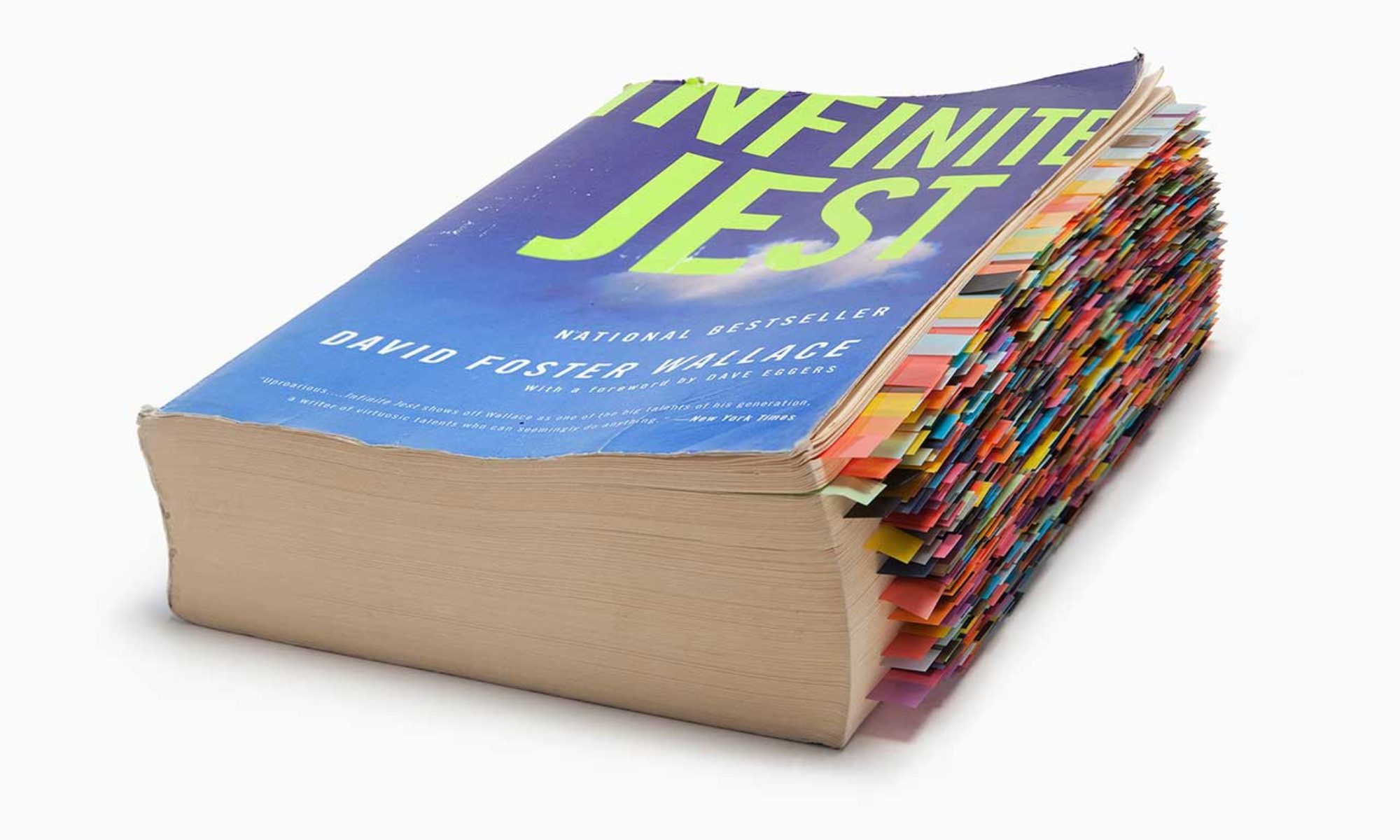Non è complicato.
Ci hanno detto di stare a casa, per evitare che il bombardamento faccia crollare il servizio sanitario nazionale.
Sei un dipendente? Rompi le scatole al tuo datore di lavoro, mandagli il decreto dell’8 marzo. Resta a casa, stai buono, e non fare casini. Non ti muovere, non tornare a casa da mammà: ogni volta che ti muovi è un rischio in più che corri tu e fai correre soprattutto ai tuoi amici e congiunti che non corrono la maratona come te. Se c’è uno con l’asma, uno immunodepresso, una nonna che ormai è avanti con gli anni, sono soggetti a rischio: statti alla casa, rischi di più ad andarla a trovare la nonna che a non farlo. Non ci sono scuse, non c’è giustificazione: la paura non giustifica alcun comportamento anti-sociale, come quello di chi ha provato a “scappare” sabato sera da Milano e dal resto delle regioni del nord. Quelli sono i comportamenti che rischiano di far naufragare gli sforzi della sanità pubblica di far fronte all’aumento di pazienti che necessitano di cure.
Sei un datore di lavoro? Permetti ai tuoi dipendenti di usare le ferie se ne hanno, se possibile attivali in smartworking, non farli andare in ufficio. Mi dicono che ci sono molte aziende che si rifiutano di capire, soprattutto qua al nord dove il decreto dell’8 marzo dice chiaramente che dobbiamo stare a casa. Non è complicato: ci hanno detto di stare a casa, stiamo a casa. Altrimenti tra 2 giorni ci militarizzano e facciamo come in Cina. Perderemo fatturato, lo capisco benissimo: il mio lavoro dipende da budget che in queste occasioni vengono subito tagliati. Le aziende non investiranno in comunicazione, tra 6 mesi probabilmente il mio posto sarà a rischio: amen. Qui parliamo di altro.
Stiamo buoni, giochiamo a Risiko e a Destiny, tra 15 giorni se va tutto bene sarà tutto sotto controllo e staremo meglio tutti. Non è la fine del mondo, non è la peste bubbonica, è solo un virus: forza e coraggio. Questo è il momento nel quale veniamo messi alla prova come Paese: siamo capaci di rispettare le regole?